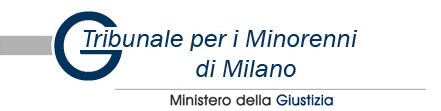Tribunale
Documenti
Accoglienza minori ucraini
Adozioni di minori con bisogni speciali
Progetti e Iniziative
Procura
Link e contatti
Glossario
Mia madre non è “la madre” - La ricerca dell’identità nelle persone adottate
Per gentile concessione dei "Quaderni di Psicoterapia Infantile" (ed. Borla) pubblichiamo l'articolo del dr Augusto Bonato, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano, tratto dal n° 68 (giugno 2013), dedicato ai "Bambini a rischio di ingiustizia"
Augusto Bonato*
Mia madre non è “la madre”
La ricerca dell’identità nelle persone adottate
Qualche anno fa il presidente del tribunale per i minorenni di Milano, dott.ssa Pomodoro, mi chiese di procedere, con altri colleghi, alle audizioni delle persone che, ritenendo di essere state adottate attraverso l’adozione nazionale, chiedevano di “accedere a informazioni che riguardano la ‘loro’ origine e l’identità dei genitori biologici” come previsto dalla legge[1]).
E’ un lavoro appassionante che svolgo ancora. Fra l’autunno del 2006 e la fine del 2010 ho istruito circa 90 fascicoli. Fornisco alcuni dati numerici che possono offrire l’idea del lavoro del T.M. di Milano in questo specifico settore.
Numero delle persone che hanno presentato istanza ai sensi dell’art.28 suddivise per anno, fasce d’età, sesso
| 0-30 | 31-40 | 41-50 | Oltre | Totale procedure | M/F | Non legittimate* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15 | 19 | 13 | 6 | 67 | 30/37 | 14 |
| 2007 | 15 | 14 | 8 | 5 | 54 | 26/28 | 12 |
| 2008 | 16 | 16 | 12 | 6 | 60 | 30/30 | 10 |
| 2009 | 12 | 17 | 16 | 4 | 58 | 29/29 | 9 |
| 2010 | 9 | 19 | 15 | 5 | 56 | 25/31 | 8 |
| Totali | 67 | 85 | 64 | 26 | 295 | 140/155 | 53 |
* sono le persone che hanno presentato istanza in assenza dei titoli: infraventicinquenni, fratelli e genitori biologici di persone adottate, non adottate.
I provvedimenti emessi nello stesso periodo (2006-2010) sono stati 244:
- 60 sono stati di ‘accoglimento’: le persone adottate sono state autorizzate a prendere visione dei fascicoli che li riguardano e ad estrarre copia degli atti in esso contenuti;
-
161 sono stati di ‘rigetto’:
- una parte perché le persone che hanno presentato istanza non erano legittimate (fratelli o genitori biologici di persone adottate, persone adottate ma infraventicinquenni)
- un’altra parte perché l’istanza era stata presentata da persone non adottate
- un’altra, molto più consistente (140 circa) perché si trattava di persone adottate nel cui atto integrale di nascita compariva la dizione ‘figlio di donna che non consente di essere nominata’
- 23 di ‘archiviazione’: persone che, dopo aver presentato domanda, vi hanno rinunciato; persone che hanno presentato istanza nel distretto giudiziario nel quale non risiedevano.
Questi elementi non sono comparabili con quelli di altri lavori sul tema che contengono risultati di ricerche scientifiche costruite su campioni rappresentativi di universi statistici definiti per tempi, territori, argomenti. In questo contributo mi limito a presentare, opportunamente velate e criptate nei dati sensibili e rese irriconoscibili per quanto riguarda la identità delle persone, alcune testimonianze autentiche, estrapolate dai colloqui, emblematiche di stati emotivi che si osservano in quasi tutti i protagonisti incontrati nella fase istruttoria.
Nella maggioranza dei casi ho ricevuto solo l’adulto che ha presentato la domanda. In altri casi, però, ho ritenuto utile incontrare e ascoltare anche persone importanti della sua vita, come prevede il comma 6: uno o entrambi i genitori adottivi, il coniuge o il fidanzato; una volta, per esplicita richiesta del presentatore dell’istanza, ho ricevuto anche il figlio della persona adottata.
Quasi tutti hanno accettato il primo appuntamento proposto e sono arrivati puntualissimi o molto in anticipo sull’ora concordata.
Ricordi
Non pochi sono arrivati al colloquio conoscendo già, con ricchezza di elementi, la propria storia pre-adottiva perché sono stati collocati nella nuova famiglia quando avevano già cinque o più anni. Ricordano i nomi dei genitori biologici, alcuni tratti del loro carattere e dei loro comportamenti e il clima delle relazioni intercorse. Conoscono naturalmente i fratelli collocati presso la stessa famiglia o presso una famiglia differente quando, talvolta, è capitato che si siano potuti mantenere i contatti fra le famiglie che hanno adottato i fratelli. Ricordano gli “istituti” dove sono stati accolti per breve o lungo tempo; talvolta nominano il giudice che ha seguito la loro vicenda di bambini in situazione di pregiudizio e li ha ascoltati prima della sentenza di adottabilità. Se erano piccolissimi e sono stati adottati assieme a fratelli più grandi, questi sono stati la fonte delle loro conoscenze e magari hanno sentito da loro che la mamma, nelle ultime visite fatte in comunità, aveva il pancione e vengono in tribunale alla ricerca del fratellino perduto.
Un signore, ora quarantenne, adottato a quattro anni, sapeva molte cose importanti. Gliene mancava una, essenziale: “Voglio sapere chi è mio padre. Porto il cognome di mia madre. Lei so chi è e dove abita, ma non la voglio vedere. Questa cosa non intendo chiederla a lei anche se lei probabilmente lo sa. Ero piccolo e vivevo con lei. Mi scaricava al piano di sotto, nell’appartamento dove abitava mia nonna, quando sotto casa arrivavano macchine bellissime con uomini diversi. Lei mi piantava lì e se ne andava. Io strillavo. Forse mio padre è migliore di lei”.
Altri si sono inventati una storia, costruita su un dettaglio di realtà, quasi il residuo di una memoria biologica sensoriale che illusoriamente ripara una ferita intollerabile. Un sedicenne, adottato a sei mesi, ha convinto i genitori adottivi, sostenuto in questo dallo psicologo che lo segue, a chiedere “informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici…per gravi e comprovati motivi” (c.4). Ha una diagnosi di disturbo della personalità di tipo antisociale. Ha al suo attivo alcuni procedimenti penali con messe alla prova fallite. Inserito in comunità psico-educativa per adolescenti sembra iniziare un percorso di responsabilizzazione e manifesta interesse per apprendere un mestiere che gli piace. Dopo qualche tempo, per motivi futili, inscena liti violente con i compagni di comunità, si ribella agli educatori e si fa espellere.
Da anni il giovane è convinto di non avere nulla in comune con i suoi genitori adottivi, che sente estranei in tutto, e di somigliare sicuramente ai genitori di nascita, di vedere il mondo come loro, di pensare come loro. Dice di appartenere a una famiglia meridionale. Da qualche tempo parla con accento approssimativo del sud, si attribuisce un nuovo cognome, ed è certo di venire da una famiglia importante di boss della mafia.
Ascolto i genitori e poi lui, che accetta che io incontri lo psicologo che lo ha seguito e lo segue, seppure con molta irregolarità per le sue assenze agli appuntamenti. Ascolta poco, è impermeabile a ogni dubbio, come se fosse ottuso, portato più ad agire che a pensare. La famiglia adottiva e lo psicologo sperano che la conoscenza dei dati di realtà possa saturare, almeno in parte, la sua lunga sete di conoscere la propria storia e possa dargli un po’ di quiete. I genitori adottivi appartengono alla piccola borghesia impiegatizia diligente e responsabile. Sono persone di buon senso e premurose, ma hanno sperimentato l’impotenza nel fare i conti con l’emergere delle angosce di perdita del piccolo e con le sue pretese avide, disperate e rabbiose che avrebbero richiesto un tenero, paziente ma anche forte e autorevole contenimento fisico ed emotivo.
Il tribunale autorizza i genitori a prendere visione degli atti del fascicolo e mi invita a leggerli al giovane perché possa dare loro significato ed essere accompagnato nell’incontro con la sua vicenda di bambino adottato.
La storia della sua famiglia di nascita somiglia a tante altre. E’ fatta di emigrazione, tanti figli ammucchiati in pochi letti sporchi di case minime e fatiscenti delle estreme periferie cittadine; lavori perennemente precari, inadempimenti all’obbligo scolastico dei bambini, malnutrizione e incuria grave, malattie infettive, baruffe con i vicini, dipendenza dai servizi sociali e infine una grave patologia psichiatrica cronica della madre, che è seguita dai servizi clinici di territorio ma si sottrae spesso alle cure e si scompensa, dopo di che riappaiono lunghe crisi di delirio persecutorio.
Il giovane, questa volta, è attento e ascolta con uno sguardo intelligente che non avevo mai osservato prima. Sembra realizzare che uno solo dei suoi convincimenti è fondato e trova radicamento nella realtà della sua esperienza bambina: l’appartenenza a una famiglia meridionale. Forse le sensazioni, le emozioni, le paure suscitate da quel mondo misero, inaffidabile e caotico dell’infanzia hanno concorso a costruire dentro di lui, insieme alle nuove esperienze di vita, una difesa di tipo grandioso, maniacale, rivendicativo, incarnato nell’idea di appartenere a una aristocrazia potente e criminale che fa “giustizia” e rimette in pari la bilancia della vita. Viene a sapere anche che la decisione di collocarlo in una famiglia adottiva era stata presa dal tribunale contro la volontà della famiglia di nascita, che aveva fatto ricorso contro il provvedimento.
Mi impressionò molto il suo commento alla fine. “Oggi ho saputo due cose buone per me: la prima, che non sono stato abbandonato dai miei famigliari; la seconda, che hanno anche lottato per tenermi con loro”.
La storia del giovane si inserisce nel contesto dell’orientamento recente del T.M., che una volta valutato con opportuna istruttoria che “l’accesso alle notizie richieste…non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente” (c.6), è quello di mettere a disposizione del medesimo l’intero fascicolo che contiene gli atti del suo percorso fino alla sentenza di adottabilità, senza alcuna censura od omissione che non sia dovuta a tutela di terzi che abbiano diritto alla riservatezza. Precedentemente prevaleva il criterio di “omettere” quelle notizie e quegli atti particolari (rapporti di polizia, relazioni sociali dei sevizi di territorio) il cui contenuto drammatico, violento, umiliante potessero generare solo sofferenza e non fossero ritenuti necessari alla conoscenza sostanziale della vicenda.
Detriti emotivi, macerie affettive depositate nella mente la cui elaborazione avrebbe bisogno di tempi incalcolabili e spesso di un valido “accompagnamento” di un clinico sensibile e forte, per essere bonificati e diventare utilizzabili per nuove costruzioni o buoni “restauri”.
Stati emotivi
Non mi sembra di poter confermare l’ipotesi o il convincimento di chi sostiene che a presentare la domanda disciplinata dall’art. 28 siano solo quegli adottati la cui esperienza sia stata insoddisfacente o addirittura fallimentare. Fra quelli che ho incontrato e ascoltato ce ne sono, e non in misura irrilevante, ma non sono la maggioranza.
Non ci è dato di sapere perché un gran numero di persone che sono state adottate 25 e più anni fa, specie dopo il 1967 (anno in cui venne promulgata la legge che prevedeva l’ adozione speciale “legittimante” con implicita la “separatezza” fra la famiglia di origine e quella adottiva) non abbiano fatto richiesta di poter conoscere le proprie origini e l’identità dei genitori di nascita.
Forse una parte di loro non ha mai scoperto di essere stata adottata. Atri non sono mai stati informati che dal 2001 la legge consentirebbe loro di risalire alle proprie origini. Ad altri ancora è bastato quello è stato loro comunicato dai genitori adottivi e, a modo loro, sono contenti così. Sicuramente un numero consistente di adottati teme di dare un “dispiacere” ai genitori adottivi e sembra loro un po’sleale e sgarbato procedere da soli senza informarli. Altri ancora hanno trovato ‘per caso’ (?!) il capo di un filo e con paziente intelligenza, sostenuti e incoraggiati da persone amiche e famigliari, poco a poco, sono risaliti al gomitolo e ai protagonisti della loro storia. Ora, con la diffusione dell’uso di internet, questa ricerca viene assai facilitata.
Una “sorella maggiore”, che era rimasta in famiglia è riuscita, dopo tanti anni, chissà come e per quali vie, a trovare la lontana collocazione di una sorella adottata quand’era piccolina e l’ha contattata inviandole una lettera. “No, i genitori no e neppure i fratelli maschi voglio vedere, ha detto lei. Mi hanno fatto troppo male. Mi piacerebbe invece incontrare il giudice che ha deciso la mia adozione perché mi ha risparmiato una vita brutta e disgraziata, e mi ha fatto trovare dei genitori adottivi affettuosi, allegri e forti che sento essere i miei veri e unici genitori. Ero piccola, mi bagnavo tutte le notti, mi svegliavo in preda al terrore e piangevo per ore e loro mi hanno restituito serenità e dignità. Non si sono mai vergognati di me e mi hanno fatto conoscere e vivere in un mondo buono e amico”.
Molte persone che ho ascoltato mi hanno parlato di genitori per i quali provavano sentimenti di stima e gratitudine e con i quali hanno potuto costruire legami affettivi solidi. Hanno goduto di una vita di famiglia, di amici, di gioco, scolastica e professionale appagante. “Ero una di loro, come loro”. E hanno avuto figli desiderati e amati. Altre hanno vissuto esperienze deludenti e, alcune, addirittura mortificanti e umilianti. “Erano troppo ansiosi, oppressivi. Non mi perdevano mai di vista. Vivevano sempre in uno stato di allarme, come se da un momento all’altro potesse presentarsi alla porta mia madre a rivendicare il figlio che le era stato ‘rubato’”.
E un bambino adottato sognava di frequente di essere stato portato alla nascita da un falco e non da una cicogna.
In passato, molto più spesso di quanto non accada oggi, era frequente che i genitori adottivi creassero attorno al figlio una cortina spessa di silenzio e/o di negazione e coinvolgessero e rendessero complici del segreto anche parenti e amici.
Questi in genere si sono rivelati segreti di Pulcinella, perché compagni di scuola o di giochi arrivavano a mettere delle pulci nell’orecchio.
Il primo comma dell’art. 28, opportunamente integrato e modificato nel 2001, dice: “Il minore adottato è informato di tale condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”.
Una sensazione che suscita una domanda
Molte persone tenute all’oscuro della propria vicenda adottiva comunicano pensieri che, raccolti e condensati, suonano pressappoco così: “Io però mi sono sempre sentito ‘diverso’ dagli altri e provavo un certo disagio. Non ne capivo la ragione, ma era così. Era come se intorno alla mia nascita ci fosse qualcosa di oscuro, di non detto e i miei svicolassero quando capitava che io ponessi loro delle domande; per esempio chiedevo perché non ci fosse neanche una foto di me piccolino prima dei due anni in braccio alla mamma o al papà, o perché fossi nato in una città diversa e lontana da dove vivevamo. Inventavano delle bugie che non tenevano a lungo e mi sentivo imbrogliato”.
Due esperienze mi sembrano significative e paradigmatiche.
Flavio aveva una quarantina d’anni. Faceva il custode di notte in una fabbrica importante della Valtellina. Vegliava armato e faceva il giro attorno alle mura dell’azienda e all’interno dei capannoni. “Nel silenzio e nel buio della notte, a volte temperato dalla luna piena e dal cielo tempestato di stelle, o rotto dal fascio di luce della torcia, mi passavano davanti agli occhi come delle scintille o provavo sensazioni e facevo fantasie che non riuscivo a comporre e a mettere insieme in una rappresentazione chiara e tradurle in parole. Poi un giorno di vari anni fa, quando mi separai dalla morosa, avvertii più netto un vuoto grande e desolato. Seduto vicino ai miei genitori ho parlato loro di questo vuoto che sentivo da sempre e ho chiesto se mi potessero aiutare a dargli un senso, un nome. Finalmente mi dissero parole vere e in quel momento capii che io quella “cosa” la sapevo fin da piccolo, ma non avevo mai voluto sentirmela dire. Eppure c’erano stati cento indizi che mi avrebbero potuto raccontare la verità, comprese le gentilezze speciali e delicate che parenti e amici di famiglia mi usavano e non avevo mai visto usare con i loro figli”.
La seconda vicenda riguarda un signore che era stato adottato piccolissimo. Dopo qualche anno i suoi genitori adottivi erano riusciti, inaspettatamente, ad avere un proprio figlio biologico. “Più crescevamo e più era evidente la nostra diversità. Non ci somigliavamo per niente, ma lui somigliava molto a loro. Quando facevo domande su questa faccenda del mio essere affatto differente da tutto il parentado, mi assicuravano che io ero uguale a un vecchio zio, disperso nella campagna di Russia.
Avendo trovato lavoro presso una agenzia di investigazioni, un giorno mi decisi a sciogliere i miei dubbi. Mi fu facile, data la mia professione, trovare la busta che conteneva i documenti della mia adozione. Ne feci fotocopia e tenni la cosa per me. Con fatica e inquietudine. Non era facile dissimulare una normalità che dentro io non sentivo più. Cambiai mestiere e mi impiegai presso una agenzia immobiliare. Finalmente un giorno mi feci coraggio. A casa c’era solo mio fratello. Ci si voleva bene e c’era confidenza fra noi. Gli posi sotto gli occhi i documenti fotocopiati dicendogli: “La sai la novità? Io non sono tuo fratello, ma sento che tu sei mio fratello”. Sbiancò, si allontanò e si chiuse in bagno. Tornò dopo poco, aveva gli occhi lucidi di pianto, e mi abbracciò con tutta la sua forza. Ora abbiamo cambiato lavoro e insieme abbiamo messo in piedi una piccola società di progettazione, costruzione e ristrutturazione di case”.
Quando e perché
La risposta più semplice sembra essere: quando le persone si sentono in grado di ascoltare quelle verità della loro vita che ancora non conoscono consapevolmente ma dalle quali si sono sentite intrigate. E’ il tempo nel quale possono dare rappresentabilità e parole a esperienze intime antiche, profonde e decisive. E sperano che queste possano dare significato nuovo e benefico al tempo, curare ferite e rendere possibili incontri e pacificazioni.
Dal punto di vista delle coincidenze e delle circostanze con fatti recenti o prossimi che hanno agito da stimolo, le risposte sono analoghe in molti casi, ma capita anche che siano affatto singolari.
“Ho appena compiuto 25 anni. Aspetto questo giorno da un sacco di tempo. I miei genitori mi hanno sempre incoraggiato a cercare le notizie importanti della mia vita di prima, breve, piccola ma fondamentale. Loro non mi hanno nascosto nulla di quanto sapevano”.
“Mi sposo fra poco. Sono qui con il mio fidanzato, ma la prima parte del colloquio desidero essere da sola. Voglio affrontare da sola le cose che riguardano me prima di ogni altro. Dopo lo inviteremo a entrare. Lui sa della mia adozione. I miei genitori adottivi non li cambierei con nessuno al mondo. La mia vita è stata bella e contenta. Mi sono sentita amata. Ho giocato tanto e ho studiato molto. Esercito una professione che ho scelto e mi piace. Vorrei poter dire alla madre che mi ha generato, se mai dovessi incontrarla e conoscerla, che se per tutti questi anni ha potuto avere dei rimorsi è il tempo che trovi pace, perché io sono stata bene e sono in pace con lei”.
“Mi è morta la mamma da qualche anno e il papà è anziano e ha vari acciacchi. Non ho fratelli; ho paura di restare solo. Ho qualche cugino da parte di mamma ma abita lontano e non ci si vede mai. Chissà se per qualche strada potrò incontrare persone della mia famiglia di prima. Vado spesso al cimitero per continuare a raccontare a mia madre le cose della mia vita”.
“Scrivo testi di teatro e faccio il regista. Scelgo gli attori e assegno loro i ruoli. Sto allestendo uno spettacolo sulla bomba ai Georgofili. Rappresento drammi, storie, talvolta, di disperazione. Ma non ho mai voluto affrontare quella parte della mia vita, quel dramma che mi riguarda e che mi è stato assegnato e deciso da altri. E’ venuto il momento”.
“Ho iniziato una psicoterapia da qualche anno. Sentivo il bisogno di conoscermi meglio per potermi orientare nel mondo e per orientare con più equilibrio la mia esistenza. Credo di essere arrivato al nucleo che forse è alla base della mia scontentezza che è antica e che, ne conviene anche il mio analista, deve avere una relazione intima con la mia adozione. Vorrei vedere più chiaro anche fuori di me, oltre che dentro di me”.
“Io faccio scappare tutti i ragazzi che mi avvicinano. Ho un bisogno di amore esagerato e si spaventano, perché io mi attacco subito, troppo. Ho paura. Ho fatto un gran casino in adolescenza e ho avuto liti tremende con i miei. Sono finita in comunità. Ora il clima di casa è migliorato. Sto facendo un corso di informatica e ho un lavoro a progetto. Da tempo, quando penso alla mia adozione faccio la fantasia di essere figlia di una ragazza come me, che è stata stuprata. E mi sento come quel giovane che lottava per la libertà e la giustizia per i popoli oppressi a un G.8 ed è stato riempito di botte da alcuni agenti di polizia ed è stato trovato in cella morto, rannicchiato a terra, solo come un cane”.
“Ho tre bambini dai 5 ai 10 anni. Vivo in campagna e mio marito conduce un’azienda agricola di tipo famigliare. Ha i calli alle mani. Pianta gli alberi da frutto, li cura e diventano grandi e generosi. So di essere stata adottata. Avevo 3 anni e ho pochi ricordi: qualche volto, ma non saprei dire di chi. L’adozione non è stata il meglio della vita. Però ho un marito buono e affettuoso. I bambini sanno che sono stata adottata da piccola. Vanno a scuola e capita che, per cominciare a studiare la storia, qualche maestra pensi utile partire da quella più vicina delle famiglie e dei paesi. Disegnano alberi genealogici. Dei genitori e dei nonni del papà sanno tutto e vorrebbero riempire i rami che rappresentano la mia famiglia di nascita”.
Reazioni
Come reagiscono di fronte all’ipotesi di poter accedere a informazioni che non conoscono, contenute nel fascicolo relativo alle proprie origini, qualora il T.M. li autorizzi alla visione degli atti?
Il giudice delegato alla loro audizione li informa che, una volta emesso il decreto definitivo della adozione che li riguarda, il T.M non ha più avuto ragione di raccogliere notizie ulteriori sui loro genitori originari. Non sa se siano ancora vivi, dove abitino, se abbiano avuto altri figli dopo il loro collocamento nella nuova famiglia e quale sorte sia loro toccata. Soprattutto non sa se siano disponibili a incontrarli o no.
Sembra che la maggior parte delle persone intenda fermarsi alle informazioni che troveranno perché non è loro intenzione andare a sconvolgere la vita di nessuno e non vorrebbero mettersi in condizione di sentirsi rifiutati di nuovo. Altri sperano invece che possa essere l’occasione per ricucire il tessuto strappato di una vita e operare un rammendo efficace e pacificatore. Intendono procedere con prudenza facendosi consigliare e aiutare da persone affidabili prudenti, senza fretta e accelerazioni rischiose.
Come reagiscono invece alla notizia che, nel loro certificato di nascita integrale, compare la dizione che sono figli di donna che non consente di essere nominata”?
Di seguito riassumo le espressioni che più di frequente capita di ascoltare. Il tono della voce, il volume, le emozioni che traspaiono sono vivissime e talvolta molto toccanti.
“E’ mai possibile che io debba morire senza aver conosciuto chi mi ha fatto nascere? Io avrei desiderato conoscere la sua storia e capire che cosa le abbia fatto deciderei di non riconoscermi dopo avermi partorito. Quando mi è stato adagiato al seno il mio bambino appena nato e ho potuto stringerlo e baciarlo, ho sentito che io non avrei mai potuto abbandonarlo”.
“Avrei voluto fare pace con lei e stare in pace con me stessa; speravo, incontrandola, che il male che mi porto dentro potesse essere accantonato per sempre e trovare nel passato, finalmente accettato, il suo giusto posto”.
“Che grande peccato! Sono venuta piena di speranza e di desiderio. Immaginavo di poter incontrare i miei genitori e dire loro: ‘Avete tre bei nipotini. E io, in fondo, mi posso chiamare fortunata… Ah sì!? Sono figlia di donna che non consente…Come si è permessa? Ora non mi interessa più neanche il suo nome, ma solo sapere perché mi ha rifiutato. Bastava un foglietto, mezzo foglio di quaderno, anche senza firma, che dicesse: ’Ho 19 anni, sono stata violentata e buttata via. Non ho né casa né lavoro e i miei non sanno niente, perché vivono al paese e io sono venuta qui per trovare lavoro e futuro’. Mi bastava. Sapesse la rabbia e l’odio che provo. E’ grande e terribile. Ma non finisce qui. Per vie legali o illegali io prima o poi la troverò. Mi bastano cinque minuti. Non la tocco, ma guai a lei. Anzi è meglio per lei se è già morta”.
Un altro ha girato il mondo, specie i paesi del nord e in oriente. Laureato in discipline umanistiche, scrive e parla correntemente tre o quattro lingue. Lavora con funzioni dirigenziali in una multinazionale che organizza convegni scientifici. Non ha ancora trent’anni. La sua famiglia adottiva appartiene alla borghesia colta del pavese che lo ha molto incoraggiato e arricchito sul piano delle conoscenze e della professione. I suoi genitori sono sempre stati molto attivi a livello sociale e politico e lui, ancora piccolo, spesso si sentiva come messo in un angolo, perché gli mancava l’intimità con loro. Non gli hanno mai nascosto nulla di quanto sapevano. Gli hanno mostrato la sua cartella clinica di dimissione dall’ospedale dove è nato con dei problemi legati alla sua significativa prematurità. I tempi fra la sua nascita e il suo collocamento in famiglia erano stati abbastanza brevi e facevano supporre a tutti che potesse essere un bambino non riconosciuto. Lo hanno sostenuto nel suo desiderio di conoscere di più.
Alla notizia che dal suo fascicolo, purtroppo, risultava essere figlio “di donna che non consente di essere nominata”, questo giovane uomo, teso e attento fino allo spasimo, dopo un breve momento di stupore incredulo, esplode in pianto denso di dolore e di rabbia. Parla a fiotti, col ritmo di violente mareggiate. “Questo paese è stupido. Nessun paese è così pazzo come questo. Sono stato abbandonato alla nascita, da una madre che non ha avuto nemmeno il coraggio di farmi sapere il suo nome. Perché lei ha il diritto di rifiutarmi e io non ho il diritto di sapere chi è e perché lo ha fatto? Solo le madri hanno diritti e i bambini no? E se ha deciso di abbandonarmi e sparire, io almeno dovrei sapere perché lo ha fatto. Magari potrei anche capire e perdonarla. Ma così no, non è giusto. Tutto questo è pazzesco e mi fa impazzire. Altri paesi del nord hanno leggi più umane e non vengono negati questi diritti per tempi biblici. Ma supponiamo che mia madre, nel corso del tempo, si sia pentita e sia venuta qui a cercarmi, dieci anni fa, lo avrebbe potuto fare e avere una risposta puntuale? No?! Allora io sono proprio come i figli dei desaparecidos, con i genitori o la madre violentata e poi uccisa e non la potrò mai più vedere, incontrare e parlarle. Ma lei lo sa quanti siamo noi ‘figli di genitori scomparsi’ che navighiamo su internet e cerchiamo, come piccole formiche, di costruire gallerie nel profondo della terra e del tempo, sperando di afferrare un filo che ci riporti a casa? Io impazzisco. Ogni donna di capelli e di carnagione chiara e occhi verdi che incontro, la fisso e penso ‘potrebbe essere lei, magari è proprio lei mia madre’. Non può immaginare la disperazione delle persone come me. Tutto questo è ingiusto, offensivo e crudele”.
Carla viene col marito. Si è sposata da poco. Ha l’aria contenta. Sono giovani e belli e pensano a un bambino. “Credo di sapere da sempre di essere stata adottata. Non ricordo di aver provato sentimenti di rabbia nei confronti della mamma di prima. I genitori che mi hanno desiderata, aspettata e accolta come figlia loro, e sono i miei genitori per sempre, sono stati buoni e pazienti con me, perché sono una testona e, nel tempo delle rivolte di adolescente, sono stati fermi , si sono anche arrabbiati, ma non hanno mai cessato di farmi sentire quanto mi amassero. Sono entrata in una famiglia dove c’era già un grande pastore tedesco femmina, il cane più buono del mondo. Io la mordevo da per tutto, le torcevo la coda e lei, povera, mi leccava. A Carnevale, avevo quattro o cinque anni, mia madre mi cucì un bel vestitino da Cappuccetto Rosso e io andavo in giro per il paese con il ‘cattivissimo lupo’ al guinzaglio. Ora noi abbiamo due cani meticci e di taglia diversa e i miei genitori, a casa loro, ne hanno altri due. Tutti cani abbandonati e trovati al canile”. Quando apprende di essere una bambina non riconosciuta, sembra provare uno stringimento di cuore e una profonda pietà: “Forse era giovane, forse era sola, forse non si sentiva di tenere una bambina che era stata frutto di una violenza. Se la potessi incontrare le vorrei solo dire grazie per avermi dato la possibilità di una vita buona e normale. Peccato! Mi manca solo questo anello per unire i pezzi della mia vita”.
Paolo è poco più che venticinquenne, di origine africana. Sa di essere stato abbandonato quando era piccolissimo da una madre che è scomparsa. Forse è tornata al suo paese. Nessun parente in Italia. E’ stato adottato da una famiglia del comasco che aveva due figli maggiori di lui di qualche anno. Ha degli occhi belli, neri e tristissimi. Parla sottovoce e pronuncia frasi brevi. “Non mi sono mai sentito ‘figlio’ come gli altri. Mi trattavano e mi sentivo come un ‘ospite’ accolto per carità. Quando toccavo qualcosa in cucina o in sala mi sembrava che provassero fastidio, come per un invitato che si prende troppa confidenza in casa d’altri. Al contrario i miei compagni di scuola, di basket, di oratorio e i miei allenatori non facevano differenze fra noi”. Poche volte mi è capitato di avvertire in una persona una solitudine e una sofferenza così totale e cupa, un rancore antico e pietrificato per una umiliazione lunga di anni. Difeso dal dolore come da una muraglia impenetrabile. Nulla sembrava poterlo intenerire, consolare, risarcire. Mai l’accenno di un sorriso. Nessuna speranza, nessun amore. Chiede solo se può togliersi di dosso il cognome della famiglia adottiva. E’ uscito di casa da un paio d’anni. Vive in un piccolo paese. Fa l’operaio e un po’ di atletica leggera. Non ha amici importanti per lui, non mi parla di alcun interesse che gli procuri qualche piacere. Sembra concentrato solo sull’unico obiettivo di cambiare cognome, illudendosi che, una volta realizzato, otterrà un trionfo vendicativo sulla famiglia adottiva e potrà ‘nascere di nuovo da solo’. Nessun rimpianto per una madre che, forse, immagina provasse per lui piccolino un fastidio come per un “ospite” inatteso e indesiderato.
Marco racconta che tanti anni fa, quando iniziò il catechismo in preparazione alla prima comunione, la maestra presentò tutti i bambini ai compagni. Di lui disse: “Marco è un bambino proprio speciale, eccezionale come nessun altro di voi, perché è un bambino adottato”. Tornò a casa pieno di fierezza e chiese alla mamma che cosa volesse dire la parola ‘adottato’. La madre si impappinò e farfugliò qualcosa così: “Sai, tu sei il nostro bambino, noi siamo la tua mamma e il tuo papà. Sapessi quanto ti abbiamo desiderato e quanto sia stato bello averti con noi. Ma tu hai avuto un’altra mamma prima di me che noi non conosciamo”. Ora aggiunge: “Forse è da quel tempo che mi accompagna un dolore e una rabbia, una paura che rende la mia vita tormentata e scontenta. Non mi manca nulla: un titolo accademico prestigioso, un lavoro interessante nel quale ho fatto una carriera ottima. Per anni ho praticato con passione vari sport, alcuni a livello professionistico partecipando a gare nazionali e internazionali, ottenendo risultati molto buoni. Mi piazzavo far i primi tre o quattro. Ma non sono mai arrivato primo. Mi alleno ancora e vado allo stadio al mattino presto, prima che il sole spunti e poi alla sera quando è buio. Desidero stare solo dentro le mura, ascolto musica con gli auricolari e corro, corro. Talvolta vado al mare e al buio, la notte, mi tuffo. Ore di bracciate. Sento che quello è il mio elemento. Mi sento contenuto in uno spazio morbido, soffice, come se venissi cullato dall’acqua del mare”, incrocia le braccia a forma di grembo e le muove delicatamente come se cullasse un bebé. E’ tenerissimo e commosso.
“La mia vita è come un film. Il primo fotogramma è stato ‘scartato’ e tutta la storia, da quel gesto e da quel momento, si è svolta in una forma sicuramente diversa da quella che avrebbe dovuto essere. Quella cosa del principio ha segnato tutta la mia esistenza e tutti i miei rapporti. Ho avuto due genitori che mi hanno voluto e mi vogliono ‘troppo’ bene, al punto che non ho visto l’ora di prendere le distanze di sicurezza dalle loro premure per non sentirmi soffocare. Sono convinto che siano vissuti con la paura che me ne andassi, o che qualche donna venisse a richiedermi. Loro sanno però che possono contare su di me, perché tutto quello che io sono lo devo a loro.
Non sono capace di impegnarmi in nessun legame. Ho incontrato, conosciuto e frequentato tante ragazze. Mi interessano, le desidero e sento di essere desiderato. Provo trasporto per qualcuna, ma non riesco mai a radicare e a consolidare alcuna relazione. Quando percepisco che si accende in me un sentimento forte, mi allontano e abbandono la persona che lo ha suscitato. Forse mi spaventa il pensiero di poter essere abbandonato di nuovo. Temo che non reggerei.
Ecco, vorrei incontrare la madre che mi ha partorito, porle una sola domanda: ‘perché’, e poi congedarmi. Non mi importa nulla che altri possano essere stati male, che lei sia stata male, magari peggio di me. Sento che il mio tormento non si placa. Ho avuto anche dei colloqui con uno psicologo, ma mi pare di non averne tratto gran giovamento”.
E conclude: “Vari anni fa presentai domanda ai sensi dell’articolo 28. Ero molto ansioso per l’attesa e allora mi buttai a testa bassa nel lavoro. Non arrivava alcuna risposta. Mi dicevo: sono i tempi della giustizia. Alla fine, dopo tre anni, tornai in tribunale e chiesi notizie. L’impiegato mi rispose che già da parecchio tempo mi era stato spedito, con raccomandata, un decreto che io non ho mai ricevuto, forse perché avevo cambiato residenza nel frattempo. Mi assicurò che me ne avrebbero fatto avere copia. Qualche settimana dopo ricevetti il decreto che diceva pressappoco: ‘in riferimento alla sua istanza del… fascicolo n. …essendo figlio di donna che non consente di essere nominata, la sua domanda è ‘rigettata o respinta’, non ricordo bene le parole precise. Vi è mai capitato che dopo una comunicazione così qualcuno si sia ucciso?”.
I non aventi diritto
Nel corso di questi ultimi anni sono state presentate domande ai sensi dell’art. 28 da parte di persone che non risulta siano state adottate. Ne ho incontrate almeno tre. Tutte e tre erano maschi e di età molto diverse. Il T.M. avrebbe potuto rispondere con un decreto di “non luogo a provvedere” che significa: non essendoci stata nel suo caso alcuna pronuncia di adozione, il T.M. rigetta la sua richiesta perché priva di fondamento giuridico. Sembrava una maniera spiccia e burocratica di evadere una domanda che sicuramente nasceva da motivazioni soggettive importanti. Si ritenne opportuno e rispettoso accogliere e ascoltare anche queste persone e accompagnarle alla conoscenza della “verità legale” che può rivelarsi indicazione e preludio a cercare, in un altro “archivio” e per un’altra strada, significati nuovi alle loro esperienze drammatiche del passato.
Uno di queste persone era molto giovane. Nel corso della telefonata di convocazione per un colloquio, si sente la voce di un piccolino, accanto a quella dell’adulto. Giorgio si presenta al colloquio con molta ansia. Volto pulito, un sorriso timido. Chiaro e ordinato nei pensieri e fiducioso. “Io non sono mai vissuto con i miei genitori. Fin da piccolissimo sono stato curato dalla nonna e sono vissuto nella sua casa. Era la madre di mio padre. Fino all’età di 14 anni, quando è morta. Era stata colpita da un ictus, e non reagiva più, non dava più segni di vita. Ho telefonato in fabbrica cercando mio padre per dirglielo. Mi ha risposto a male parole: ‘Non mi rompere.. sto lavorando’. I miei genitori, a Natale, andavano dai parenti, io stavo con la nonna, noi due soli. Andavano in vacanza d’estate, io non ho mai fatto un giorno di vacanza con loro. Mio padre faceva l’operaio e la sera, quando terminava il turno, andava a bere. Tornava ubriaco e menava mia madre e, quando i miei sono venuti a vivere in casa della nonna, mi nascondevo in uno sgabuzzino per il terrore. Veniva a cercare anche me e mi massacrava. Mi offendeva e mi umiliava. In lui c’era solo odio. Non ricordo di lui né una parola né un gesto gentile. Mia madre non ha mai preso le mie difese.
Sul lavoro ho conosciuto la mia compagna. Ha 15 anni più di me. Ci vogliamo bene. Abbiamo un bambino. E’ bello, simpatico, sta bene. Sentendo come i miei mi trattavano, la mia compagna mi ha messo una pulce nell’orecchio: ‘possibile che due persone così possano essere i tuoi veri genitori?’. L’avevo pensato anch’io. Spesso, di notte mi sveglio all’improvviso tutto sudato e pieno di terrore. Incubi”.
Ricongiungimenti
Giovanna aveva 73 anni quando si recò in tribunale. Conosceva già il contenuto del suo atto di nascita integrale, dove si poteva leggere che era “figlia di donna che non consente di essere nominata”. Però, in cuor suo, pensava che nei fascicoli del tribunale qualcosa di più ci fosse scritto, qualcosa che potesse rispondere al suo bisogno di conoscere. “Prima di morire, diceva, o prima di diventare del tutto rimbambita”.
Desiderò raccontare la sua lunga storia. Era nata a Varese. C’era la guerra e la fame. L’istituto di protezione dei bambini senza genitori la collocò “a baliatico” presso una famiglia di contadini del comasco che viveva in una grande cascina. La mamma si chiamava Angela e il papà Giobatta e avevano 6 bambini. La settima era una bambina, morta pochi giorni prima; era appena nata.
Giovanna ne prende il posto nel cuore e nel seno di Angela. Dorme nel lettone coi “genitori”, e poi, nella piccola culla col materasso di foglie di granturco. Cresce, parla il dialetto del luogo. In casa nascono altri due bambini dopo di lei. La balia le chiede spesso. “Come mi chiamo io? Come si chiama il ‘papà’?, e i tuoi fratellini, come si chiamano? Dove abitiamo? Queste cose tu le devi sempre ricordare”.
Giovanna compie 7 anni. Angela e Giobatta decidono di fare domanda di adozione per averla come propria figlia per sempre, anche a livello giuridico. Ma poco tempo prima, all’istituto di Varese dove era stata collocata Giovanna subito dopo la nascita, si erano presentati due signori molto ricchi e gentili che desideravano un bambino. Da qualche anno portavano il dolore di aver perduto la loro unica figlia, morta subito dopo la nascita. Non riuscivano ad avere altri figli per una sopravvenuta sterilità del marito.
Una mattina di buonora, il ‘papà’ Giobatta accompagna Giovanna a Varese. La affida a una suora che la sta aspettando e le dice: “Ti vorrà bene, avrà cura di te fino a quando tornerò”. Giovanna si spaventa, piange, grida il suo strazio vedendo il ‘papà’ allontanarsi. Piange anche lui. Si ferma, si gira, la saluta ancora una volta ed esce dal portone. La suora tenta di consolarla. Poi le pone fra le mani una scopa, come a una bambina brava e servizievole che sa già occuparsi della cura della casa. Arrivano, dopo poco, i due “signori”. La guardano, le sorridono.
Lei capisce tutto, subito, e si nasconde dietro il gonnellone della suora. Non li vuole. Le parlano in modo garbato e le propongono di andare con loro in un bellissimo ristorante della città. Sente che ogni resistenza è inutile, e ci va con infinita tristezza. Non tocca cibo. Neanche un boccone del dolce buonissimo. Le dicono: “Da questo momento tu sei la nostra bambina e noi siamo la tua mamma e il tuo papà”. Giovanna non vuole chiamarli mamma e papà e si rifiuta di mangiare. L’accompagnano in una villa meravigliosa con un parco sconfinato sulla riva del lago di Varese. “Questa ora è la tua nuova casa” le dicono.
“Non ho toccato cibo per alcuni giorni. Deperivo. Tentavano in tutti i modi di convincermi a riprendere a mangiare. Con le promesse più belle per un bambino. Io continuavo a chiamare per nome la mia ‘mamma Angela’ e il mio ‘papà Giobatta’ e tutti i miei otto fratellini della cascina vecchia. A voce alta. Spaventati, chiamarono d’urgenza un medico di bambini sapiente che, sentito il loro racconto, davanti a me disse loro: Se non volete che Giovanna muoia, fatele incontrare i suoi vecchi genitori di Como e i suoi fratelli e, mi raccomando, che non li perda più”.
Giovanna ricorda tutto con una grande precisione e aggiunge: “Il giorno dopo, ero sul balcone della mia camera che guarda il parco e il viale che porta al grande cancello di entrata alla villa. E vidi avvicinarsi la mia ‘mamma’ e il mio fratello più grande. Eh! Quel momento, l’abbraccio e le emozioni che provai, non le so dire. Stemmo insieme, ci parlammo a lungo, pranzammo con i signori della casa. Passeggiammo nel parco. Al momento del congedo, dopo alcune ore, ‘mamma Angela’, stringendo le mie mani di bambina fra la sue, grandi e un po’ ruvide per le tante faccende della cascina, mi disse: “Ora ascoltami bene Giovanna: da adesso promettimi che chiamerai Claudine, mamma e Alberto, papà. E devi mangiare tutti i giorni, regolarmente, se vuoi diventare bella e grande e se vuoi farci contenti. Noi ci rivedremo spesso. Verremo a trovarti e, magari, un giorno o l’altro, tornerai alla cascina, con i tuoi genitori, a salutarci. Non ci perderemo più”.
Giovanna, la “bambina”, ora vecchia, estrae dal suo grosso portafogli le foto un po’ ingiallite di ‘mamma Angela’, di ‘papà Giobatta’, di mamma Claudine e papà Alberto, me le porge dicendo: “Sono molto belli, non è vero?.
Avevo tanti zii e cugini nella mia famiglia di Varese. Ma il mio arrivo alla villa aveva scombussolato i loro piani e i loro progetti sulla fabbrica e sui terreni dei miei genitori. Per loro non fui la ‘benvenuta’: tanto i miei genitori furono buoni e amorevoli, tanto loro furono sgarbati e malevoli con me. Quando ‘mamma Angela’ è stata colpita da una emorragia cerebrale ed è stata ricoverata all’ospedale di Como, l’ho assistita per tre giorni e tre notti, fino a quando è morta.
Mi sono sposata con un uomo che ho amato molto. La nostra prima bambina è morta 15 giorni dopo la nascita, per l’insipienza del neonatologo. Poi ho avuto un figlio che ora ha 35 anni. E’ un bravo architetto e un buon figliuolo ma, per ora, non intende né sposarsi né avere bambini. Che peccato e che delusione!
I miei genitori sono ‘tutti’ morti. Li ho amati e ne sono stata ricambiata. Mi manca solo una tessera nel mosaico: un nome, una foto, una tomba della mia prima madre. Prima di morire, perché ho un tumore. Non so se sia stata una prostituta o, piuttosto, una giovane ragazza sola, senza un amore e senza un focolare. Come avrei voluto poterla abbracciare e conoscere”.
Come e cosa “ri-trovare”
Quasi tutte le persone che si rivolgono al tribunale per ottenere notizie sulle proprie origini, sulla loro storia “di prima”, e per conoscere il nome dei genitori di nascita, sono mosse da un desiderio trepidante e dalla speranza di ri-trovare le parti ignorate, dimenticate e nascoste della propria vita per poterle integrare. Ogni identità è fecondata da tutte le esperienze e da tutte le identificazioni, specie quelle con i genitori adottivi e i genitori originari conosciuti o fantasticati. Tutti ci dissetiamo all’acqua di mille sorgenti.
Se i genitori adottivi sono capaci di profonda empatia per il figlio, se sono serenamente sicuri di sé e dei propri affetti e non si vivono in competizione con i genitori biologici, verso i quali non nutrono sentimenti ostili, sanno cogliere i segnali che il piccolo figlio manda loro e gli affetti che esprime, e li custodiscono nella loro mente e li elaborano e, poco a poco, lo raggiungono emotivamente là dove si trova e lo aiutano a fare pace dentro di sé, a costruire ponti solidi e a riannodare legami spezzati.
Una bambina, andata in adozione a 5 anni, era figlia di una giovane affetta da una severa patologia psichiatrica, che l’aveva esposta in più occasioni a gravi rischi di morte e che non aveva alcun parente disposto a prendersi cura di lei e della piccolina. La madre, con ostinazione, rifiutava ogni cura e ogni aiuto.
Da alcuni mesi la piccola era nella nuova famiglia e stava giocando sul tappeto con alcune famiglie di cavallini, accanto alla mamma adottiva. Inventava storie. La madre la osservava con interesse e notò che c’era una cavalla che sferrava dei calci violenti per allontanare il suo puledrino. Il piccolo cercava di riavvicinarsi e lei lo buttava ancora più lontano. “Ma perché dà quei brutti colpi al suo piccolo?”, chiese la mamma.
“Perché lui è cattivo e disobbedisce sempre, e non mangia tutta la pappa che lei gli mette nel piatto”.
(La mamma naturale, in realtà, era terrorizzata dalla fantasia ossessiva che la sua bambina potesse morire di fame e la forzava a ingoiare quantità di cibo impossibili che la bambina vomitava subito dopo).
“Ma le mamme, anche se si arrabbiano, sanno perdonare i propri bambini quando non si comportano bene . Dopo averli richiamati, fanno pace con loro”, aggiunse la mamma.
La bambina, ferita: “La mia mamma di prima, no”.
Son passati due anni. La bambina, una sera, poco prima di andare nella sua cameretta, é di nuovo accanto alla mamma, sul divano. La testa, con i bei capelli biondi, é posata sulla sua spalla.
“Ti piacciono i miei capelli, mamma?”
“Sono bellissimi, mi sono sempre piaciuti, fin da quando ti ho visto per la prima volta, era mattina e il sole li illuminava nel giardino”.
“Sono come quelli della mia mamma di prima”.
“Ti ha fatto un bel regalo, doveva essere bella la tua mamma.”
“E il mio nome, mamma, ti piace?”
“E’ il nome di un fiore semplice e bellissimo, che a me è sempre piaciuto molto. Ricordi? Papà ne portò a casa un grande mazzo il giorno nel quale tu sei venuta a vivere con noi e spesso, nei giorni delle tue feste, ne porta a casa mazzi ricchissimi”.
“Anche questo nome me lo ha dato la mia mamma”.
Climi emotivi e parole che, poco a poco, riannodano fili e ricompongono pezzi di una vita spezzata.
Stefano è un quarantenne quando arriva in tribunale con la speranza di ricomporre il ‘puzzle’ della sua vita. Da piccolo costruiva con i lego castelli con le mura, ferrovie, città piene di case e di strade. Cresciuto, si era appassionato ai ‘puzzle’ con migliaia di tessere. Collezionava da tempo dischi con le canzoni degli anni in cui era nato. Amava le civette e i gufi e si recava spesso, la notte, nei boschi vicini al suo paese, per cercarli e ri-chiamarli. Da poco si era appassionato all’astronomia e si era comprato un telescopio. Voleva conoscere le stelle e il loro nome e ammirarne le costellazioni e, magari, leggervi il proprio destino, come facevano alcuni popoli nell’antichità.
Caterina, laureata in pittura all’Accademia di belle arti di Firenze, per anni aveva usato per i suoi quadri solo il nero-bitume, più o meno diluito. Il tema dominante era ‘la maternità’, una sequenza interminabile. Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed esposto presso gallerie importanti. Quando arriva in Tribunale dice: “Da un po’ di tempo nei miei quadri, finalmente, compaiono colori sempre più chiari, pieni di luce. Forse è arrivato il momento di fare luce anche sul tempo lontano della mia prima vita, finora avvolta nel buio e nel silenzio”.
Silvana, una professoressa di scienze naturali, pratica con passione due sport singolari: la discese nelle profondità della terra, la ricerca speleologica in gruppo, e l’immersione nel mare in apnea, a livelli, nei quali il rischio di soffocamento e di embolie è presente e va prudentemente calcolato e governato. Luoghi, spazi, cavità come parti materne e rischi come traumi della nascita, degli abbandoni e delle rotture dei legami fondamentali.
Elaborazioni differenti e lunghissime, che appaiono, a una lettura profonda, come rappresentazioni e forme di approssimazione simbolica al cuore del problema e del mistero che inquieta le persone alla “ricerca del tempo perduto”. Difficile, forse impossibile, dire se approderanno a qualcosa che sia in grado di trasformare la loro esistenza.
“Credo che una parte importante della mia vita, quella fino ai sette anni, quando sono entrato come figlio adottivo nella nuova famiglia, sia stata dimenticata, cancellata. Non mi sembra una cosa normale. Ricordo solo che sono stato portato di qua e di là più volte. Poi, in una buona comunità, piccola, dove ho provato, per la prima volta, con timore e meraviglia, il piacere di coccole delicate di persone grandi e gentili. Nella nuova famiglia mi sono sentito come un ‘principe’, purtroppo mai come un ‘figlio’, specie dopo che ai genitori adottivi è nato un figlio biologico, mio fratello, col quale peraltro ho un buon rapporto. Forse sono io che non mi lascio andare alla confidenza e alla partecipazione piena e semplice al clima buono di casa, dalla quale mi sono allontanato, per vivere in un mio piccolo appartamento. Qualche anno fa il dolore mi schiacciava e ho chiesto aiuto a una psicologa. So che la conoscenza dei fatti della mia infanzia, da sola, non basta a risolvere i miei problemi di relazione e sentimentali. Forse però, sapere da dove vengo, cosa mi sia successo e perché, mi è necessario per capire un po’ meglio ‘ chi sono io’. Spero che ricostruire i momenti del mio passato mi aiuti a ritrovare anche le emozioni di allora, a riviverle e a lavorarle dentro di me, magari con l’aiuto della mia psicologa. Lei mi ha dato una mano per aumentare la fiducia in me stesso e per aprirmi agli altri”.
“Fin da piccola, ne ho ancora un ricordo vivissimo, sentivo un dolore così profondo e vasto che non trovava alcuna ragione plausibile perché avevo tutto quello che potevo desiderare. Era un vuoto incolmabile. In adolescenza ho percepito, acuta, la differenza e la lontananza della madre adottiva. E’ stata una lotta dura con lei per conquistare la mia autonomia. Ho sempre pensato che la ricerca della mia madre di nascita fosse un mio diritto e un mio bisogno assoluto. Ho attraversato tempi oscuri e pieni di tempeste, al limite di una grave depressione. Nell’incontro con una persona forte e delicata ho sperimentato di non essere più sola e di essere compresa nell’anima. Ora credo di poter affermare, senza presunzione, ma con serena sicurezza, di avere incontrato e conosciuto mia madre dentro di me, nel corso di esperienze emozionali vissute nella pratica della meditazione profonda e della regressione in un contesto clinico strutturato. Ora so chi è mia madre. Ho come rivissuto il momento del parto e anche il momento della nostra separazione. Non glielo posso provare. Può sembrare una cosa da pazzi, ma è così”.
L’adozione come parte di una storia
L’adozione, la condizione di figlio adottivo, come è noto, non costituisce uno stato patologico, una sindrome genetica. I figli adottivi non sono malati, ma hanno conosciuto un dolore speciale. Il solo fatto di essere stato adottato non è motivo sufficiente per dover affrontare una psicoanalisi. L’essere stato adottato è una condizione particolare, un dato fondamentale, costitutivo della identità di una persona; così come l’essere rimasto orfano della madre al momento del parto, essere nato da una madre rimasta vedova poco prima o poco dopo la nascita del bambino, essere figlio di una coppia che, proprio in coincidenza e a motivo della sua nascita si separa in un clima burrascoso; essere l’unico sopravvissuto di un parto plurigemellare…Ciascuna di queste vicende umane, e di infinite altre, è parte importante della storia particolare del bambino e della sua famiglia, e, insieme, anche ragione di una esperienza intima emotiva-affettiva-fantasmatica ineffabile. Mai le parole, da sole, riescono a rendere chiara e piena la profondità dei sentimenti più grandi.
Nella esperienza umana, nelle fantasie che suscita, l’adozione, nel cosiddetto inconscio collettivo, è percepita spesso come una stranezza, qualcosa di inquietante, perfino di infamante da bisbigliare all’orecchio o da scagliare come un insulto (bastardo!); fonte di romanzi famigliari, circondata, specie in passato, da un alone di sospetto e di mistero sacrale, come nelle tragedie greche e nei miti ebraici. Se funziona, invece, è l’unica cura conosciuta dalla specie umana, e non solo, che sia efficace per alleviare e rendere tollerabile la perdita dei genitori, specie della madre e l’esperienza traumatica dell’abbandono quasi sempre vissuto come un essere scartati, buttati via, rifiutati, e di ignorare, forse per sempre, chi ti ha portato in grembo, ti ha messo al mondo, ti ha dato la vita, chi ti ha abbandonato e, soprattutto, perché.
Quand’è che si può dire che l’adozione ha ‘funzionato’? Quando ha consolato e alleviato sofferenze, medicato ferite, ridato il gusto di vivere e il sentimento finalmente sicuro di essere stato cercato, amato, prediletto, raccolto là dove eri stato lasciato cadere; la consapevolezza di essere stato addirittura, ‘scelto’ come figlio desiderato e insostituibile; quando gesti e parole hanno toccato alla radice del dolore e lo hanno reso tollerabile, comprensibile. Michel Quoist, in una lirica che parla dell’adozione, mette queste parole in bocca al bambino: “… io voglio che vengano silenziosamente a chiedermi se io desidero adottarli come miei genitori del cuore. Ma non voglio dei fanatici del bambino…perché non sono fatto per salvare genitori dalle membra amputate, loro sono fatti …per salvare dei bambini dal cuore malato, forse anche condannato…voi innesterete le vostre vite sulla mia crescita selvatica, e grazie a voi io rinascerò una seconda volta…e se in una sera di tempesta, adolescente focoso, io vi rimprovererò duramente di avermi accolto, non vi addolorate…lo sapete, perché un innesto prenda, ci vuole una ferita, e, chiusa, rimane la cicatrice”.
E’ così che, finalmente, il bambino adottato si può abbandonare con fiducia ai suoi genitori che, altro paradosso, non sono i suoi genitori, e lo sa, eppure lo sono, assolutamente, non tanto in virtù di una sentenza inappellabile, ma perché li vive e li sente così, semplicemente. Non si nasce mai una volta sola. Così Winnicott, sensibilissimo pediatra e psicoanalista di bambini: “Quando sono nato mia madre mi ha sorriso”. Si possono dare altri sorrisi che ri-animano vite spente.
C’è un ulteriore definitivo passaggio che rimane da compiere. Passaggio che però non appartiene esclusivamente ai figli adottivi. Rappresenta il compimento della maturazione di ognuno. Presuppone i passaggi precedenti, li supera e li unifica. Consiste nell’arrivare alla serena certezza che “ci si appartiene e ci si può abbandonare a se stessi”, con una fiducia che non è mai risparmiata dalla trepidazione e dal dubbio.
Anna Frank, quattordicenne, destinata alla camera a gas con quasi tutta la sua famiglia nel 1945, scrive nel suo celebre “Diario” [2], mentre vive nascosta e braccata dai nazisti in un solaio di Amsterdam: “Mia madre non è ‘la madre’, io stessa devo essere mia madre”
*Psicologo, psicoterapeuta, giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Milano.
[1] ) Art. 28, legge 4 maggio 1983 n. 184 così come sostituito dall’art. 24, legge 28 marzo 2001, n.149, c.3-7.
[2] Anna Frank, Diario, Giulio Einaudi editore, Torino, 1980, pg.52.